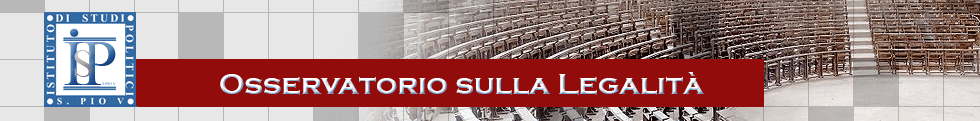La cronaca offre ormai giornalieri casi di scontro tra politica e magistratura, non solo in Italia come mostra la vicenda Le Pen. Ciò che va emergendo è che lo contro non è più solo coi pubblici ministeri, ma anche con la magistratura giudicante.
In Italia con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul trattenimento in mare di emigranti, lo scontro, forse per la prima volta, ha coinvolto le massime espressioni della magistratura e della politica.
È noto che in prima istanza il Tribunale di Roma aveva ritenuto che non consentire per alcuni giorni lo sbarco di emigranti dovesse considerarsi “atto politico”. Le Sezioni Unite della Cassazione invece, dando una loro interpretazione a principi costituzionali e della Convenzione Europea dei diritti umani, hanno ritenuto che fosse nella loro competenza definire quando un atto possa essere qualificato come “politico”, concludendo, per il caso specifico, in senso negativo e condannando perciò il governo al risarcimento.
Non si è ancora spenta l’eco di quella vicenda che un nuovo fronte è stato aperto sempre dalle Sezioni Unite, in materia di genitorialità e filiazione. Il massimo organo giudicante ha bocciato la scelta degli attuali governanti di ripristinare sulle carte d’identità dei figli minorenni la dicitura padre e madre in luogo di genitore 1 e genitore 2, ritenendola “irragionevole e discriminatoria”, perché, a suo giudizio, mostrerebbe di non prendere in considerazione tutte “le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione”.
Senza entrare nel merito della complessa questione, non v’è chi non veda che ci si trovi di fronte ad un conflitto tra principi. La Cassazione, in nome dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, ha ritenuto di sacrificare ciò che l’autorità politica aveva invece ritenuto prevalente: la ’naturalità’ umana e il senso stesso della ‘dignità dell’uomo’, che postula anche il riconoscimento della specifica, irripetibile, identità individuale e la conseguente ’diversità’ nella genitorialità.
È chiaro dunque che nelle decisioni della giurisdizione non ci si appella più a precise norme ma a principi che, per la loro astratta elasticità, non solo si prestano a interpretazioni le più varie, ma si presentano spesso tra loro in conflitto, come appunto nel caso della genitorialità. Quando ciò si verifica, è necessario decidere a quali principi dare prevalenza e a chi competa quell’operazione che i costituzionalisti chiamano ‘bilanciamento’, la decisione cioè di ‘pesare il valore dei principi per decidere nel caso concreto l’ordine di prevalenza.
Anni fa, nel ben noto caso Englaro, il Parlamento sollevò davanti alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione, lamentando che i giudici avessero invaso la sfera del potere legislativo in materia di fine vita, vanamente giustificando la propria inerzia in materia con l’inarrestabilità degli sviluppi scientifici. Lo scontro in quel caso fu tra i principi da applicare: il Parlamento trincerato dietro quello della indisponibilità del bene della vita (art. 2 Cost.), e i giudici dietro quelli della inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e della non obbligatorietà dei trattamenti sanitari (art.32 Cost.). La Corte, com’è noto, bocciò il ricorso del Parlamento.
Di fronte a questi scenari, continuare a sostenere che i giudici debbano limitarsi ad applicare la legge, è ripetere ciò che è in gran parte superato nella realtà. Significa non aver coscienza della sconvolgente rivoluzione intervenuta da decenni nel mondo del diritto, che non consente più di considerare il giudice bouche de la loi,
Il sacro principio dell’art. 101 Cost. (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”), dopo ottant’anni risulta decisamente ridimensionato nella reale vita del diritto.
Il tempo di un diritto contenuto nei codici e in poche altre leggi chiare, costruite secondo il classico schema di precetto e sanzione, appartiene ad un passato remoto, nel quale si chiedeva al giudice la meccanica applicazione di quanto statuito dal legislatore.
Questo modo d’intendere il diritto si affermò con la rivoluzione illuministica che pose fine alla secolare stagione di un diritto di natura giurisprudenziale, monopolio del ceto togato, con tutto il carico di incertezza e arbitrio (chi non ricorda il manzoniano Azzecca-garbugli pronto a trovare soluzioni per tutte le convenienze?). Con quella rivoluzione il diritto cambiò natura, affermandosi come diritto esclusivamente legislativo, con la messa al bando di interventi creativi dei giudici.
Testimone del nuovo clima è un celebre discorso tenuto da Robespierre all’Assemblea costituente il 10 novembre 1790: “La parola ‘giurisprudenza’ deve essere cancellata dalla nostra lingua. In uno Stato che ha una Costituzione e una legislazione, la giurisprudenza non è altro che la legge (tre anni dopo furono soppresse in Francia le facoltà di Giurisprudenza).
Questo programma politico aveva avuto pieno sostegno dal mondo della cultura. Cesare Beccaria qualche anno prima aveva scritto: “L’autorità di interpretare le leggi non può risiedere presso i giudici, legittimo interprete delle leggi non può essere che il sovrano come depositario della volontà di tutti. Non v’è cosa più pericolosa dell’assioma che bisogna consultare lo spirito delle leggi”.
E la legislazione recepì il nuovo corso. Lo Statuto Albertino del 1848, all’art. 73, sancì: “L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo”.
Nel Novecento, sull’onda di questa rivoluzione, gli Stati ‘forti’ poterono imporre leggi tra le più abominevoli che l’umanità ricordi.
Gli orrori della guerra e quelli ancor più esecrabili scoperti a guerra finita, nello sdegno unanime, produssero una controrivoluzione nel mondo del diritto. Come freno al potere tirannico del legislatore nacquero le Costituzioni e le varie Dichiarazioni dei diritti, che hanno fissato principi metagiuridici vincolanti per il potere politico, attribuendo la garanzia del loro rispetto alle Corti costituzionali.
Incidentalmente va detto che solo in Italia alla magistratura ordinaria è stato dato non solo il potere di eleggere un terzo dei membri della Corte costituzionale, ma anche quello di avere essa sola il potere di filtrare le questioni sottoponibili all’esame della Corte. In Francia, per esempio, la nomina dei membri della Corte costituzionale è affidata per un terzo ciascuno al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato e al Presidente dell’Assemblea nazionale, con la partecipazione degli ex Presidenti della Repubblica e il potere di deferimento alla Corte non è monopolizzato dai giudici ordinari.
Ritornando ai principi costituzionali, è ben chiaro dunque che per loro natura, essi sono aperti ad un ampio ventaglio interpretativo. Ma la Corte costituzionale, ampliando gli spazi di intervento, ha affermando che oltre a quelli espressamente menzionati in Costituzione ve ne sono altri, non scritti, ma desumibili dai “valori supremi sui quali si fonda la Costituzione”, che possono precludere interventi finanche al legislatore costituzionale. Altri fattori stanno inoltre contribuendo ad espandere il potere giudiziario. Dalla società si levano sempre nuove esigenze e nuove questioni, rispetto alle quali il legislatore, anche il più solerte, non è sempre in grado di offrire soluzioni tempestive, creando le condizioni per la supplenza dei giudici. C’è poi la tendenza inarrestabile dei cittadini di pretendere l’intervento del giudice per ogni contrarietà o presunto torto. Spesso è lo stesso potere politico che, per assecondare spinte giustizialiste, detta norme che aprono grandi spazi interpretativi in sede applicativa.
Insomma sono tante, e sempre crescenti, le ragioni per cui il giudice del nostro tempo non può essere più la bouche de la loi, ma di necessità è diventato in certa misura, compartecipe nella creazione del diritto.
Siamo in definitiva a quella “politicizzazione della giurisdizione”, preconizzata novant’anni fa da Carl Schmit. In un tal quadro non mancano realistiche ammissioni sul ruolo ‘nuovo’ cui sono oggi chiamati i giudici. Un esempio lo offre Luciano Violante, politico e già magistrato: “Questo giudice si allontana sempre più dal modello rivoluzionario e napoleonico del magistrato-funzionario e si avvicina sempre più al modello americano, componente esplicito del sistema politico. Conseguentemente questo magistrato diventa sempre più un attore politico… Di questo mutamento, però, molta parte della magistratura coglie l’aspetto del privilegio, ma ignora quello della crescente responsabilità”.
E allora sale spontanea la domanda: può il giudice del nostro tempo, ormai ‘attore politico’, essere lo stesso nato bouche de la loi, selezionato e organizzato in carriere vitalizie di tipo burocratico? Nel gran parlare di riforma della giustizia, ci si può limitare alla sola, sacrosanta, separazione delle carriere?
Allargando lo sguardo alla comparazione internazionale non si può non rilevare che nei sistemi di common law il rapporto politica-mondo giudiziario risulta meno conflittuale, ancorato com’è quest’ultimo a tradizioni di strutturata esperienza dei giudici, acquisita anche in lunghi e diversi percorsi professionali, e al realistico riconoscimento della loro partecipazione nella creazione del diritto, limitata però dal ‘precedente’, superabile con particolari cautele e adeguate motivazioni (overruling).
Nei sistemi di civil law, per i tanti rivolgimenti fin qui accennati, la vita giuridica si svolge in gran parte nella finzione che tutto sia fermo ai dogmi illuministici. Il diritto ha cessato di essere comando, parola dal suono odioso ma che – foriero di libertà o di tirannide – era garanzia di certezza, per trasformarsi in deposito di principi, dal quale si riversano sugli interpreti tutte le contraddizioni della condizione umana.
In definitiva, per quest’insieme di ragioni, oggi più che mai, è difficile negare – riprendendo l’affermazione di un grande processualista italiano, Salvatore Satta – che “il diritto è quello che i giudici dicono essere diritto”, che è poi quanto molti anni prima si è andato consolidando nel pragmatismo americano, a partire dal pensiero di Oliver Wendel Holmes che definiva il diritto:”la profezia di ciò che le corti effettivamente faranno”.
Questo quadro è la conseguenza di dinamiche storiche che hanno inciso particolarmente nel mondo occidentale. Il loro peso si fa però sentire in modo del tutto particolare nella realtà italiana, in cui l’originaria reciproca diffidenza delle grandi forze politiche aveva già riconosciuto al potere giudiziario spazi molto più ampi rispetto a quelli di altre democrazie liberali.
Diventa perciò oggi ineludibile constatare che il rigore del principio della separazione dei poteri si è relativizzato e che il principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge sta diventando, spesso anche per la rerum necessitas, il paravento di una libertà interpretativa debordante irresponsabilmente nella sfera della creatività. Non diversamente da come, l’altro principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, è diventato il paravento dell’assoluta arbitrarietà nella scelta degli obiettivi verso cui rivolgerla e dei tempi in cui esercitarla.
di Ortensio Zecchino
(Il Mattino, 16 aprile 2025, p. 38)